
Migrant story telling #03
di Valentina Avoledo
Parliamo di migranti. Il lessico si è ingentilito, si stanno estinguendo parole come “clandestino” o “vu cumprà” (troppo anni 90) ma le intenzioni sono peggiorate. Da qualsiasi parte la si guardi “l’emergenza” è riuscita a cambiare la percezione dei fatti, dividendoci in due gruppi senza sfumature in cui si è o “buonisti” o “fascisti”, segno dell’enorme deficit descrittivo di un fenomeno pieno di variabili. Ogni giorno mi chiedo se “l’emergenza migranti” sia una prova di civiltà o una scusa per impoverire quelli che si sono rassegnati alla povertà, non la povertà dei mezzi e dei guadagni, ma la povertà del futuro “a uso transitorio” e a cedolare secca.
In fondo, ognuno ha il proprio progetto migratorio: vagare da un contratto a un altro, mettere via i soldi per l’intercontinentale, imparare l’inglese, prendere lezioni di tango, partire per l’Erasmus, mangiare sushi, comprare una tenda e uno zaino da trekking, eccetera. Nessuno di questi progetti prevede la morte o la fuga da una città in guerra. Già questo sarebbe sufficiente per provare un accenno di comprensione verso chi è costretto a farlo. La questione è talmente sfaccettata che non mi sento di spenderci le trite parole che tutti osano, credo sia sufficiente ricordare come la gran parte degli interessi delle nazioni sia concentrato sul potenziale economico dei cosiddetti “paesi in via di sviluppo” e molto meno sullo sviluppo umano dei suoi abitanti. Come se il causa-effetto che regola il mondo intero non valesse per l’equazione: impoverimento = fuga.
Al di là delle analisi economiche, geopolitiche e sociali, rivendico il diritto allo sdegno verso l’indifferenza e l’ignoranza che gravita intorno all’idea comune sui migranti.
Io li conosco, li conosco personalmente. Mi occupo di insegnare loro l’italiano, lo faccio da qualche anno. Ho conosciuto diverse decine di richiedenti asilo, asiatici e africani, perlopiù uomini, per la maggior parte musulmani. Cercherò di raccontare chi sono i migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati politici, nella speranza che possano avere una voce, o magari solo un ritratto scritto. Per proteggere la loro identità chiamerò i maschi Mhm1, Mhm2 eccetera (Mhm sta per Muhammad) e Ftm1, Ftm2… (Fatima) le donne.
Mhm #03
Mhm3 ha 27 anni e quando è arrivato in Italia ha preso in mano una penna per la prima volta. È partito dall’Afghanistan a piedi, una prova che sfiancherebbe il più proteico degli iron man. Ha camminato con suo fratello che però è morto annegato mentre guadava un fiume in piena. Mhm3, per il dolore, ha preso a morsi un sasso e si è rotto tutti gli incisivi. Non ha uno sguardo sveglio, Mhm3, non è l’Einstein nascosto tra i rifugiati politici, in Italia però è andato a scuola ogni giorno, e dopo due anni e innumerevoli insegnanti è uscito dall’analfabetismo. Ora sa come impugnare una penna e ha capito che l’unione delle sillabe è il segreto per formare le parole.
Mhm3 spera di riuscire, un giorno, a superare il test di ingresso per fare un corso di saldatore, ha capito che non saper leggere e scrivere, fuori dall’Afghanistan, significa aver bisogno di assistenza per fare qualsiasi cosa, per comprare l’abbonamento dell’autobus, per prenotare una visita in ospedale o per rispondere a un Sms.
Mhm3 ha chiesto al suo compagno di stanza, che invece ha frequentato l’Università: Perché leggi? Non cosa leggi ma perché. Non si può rispondere a questa domanda senza entrare nella bolla del processo immaginifico-creativo. Un analfabeta non è in grado di organizzare lo spazio nel foglio, non sa scrivere dritto, sopra le righe, dentro al quadretto. Una frase minima è un traguardo che richiede sforzi incommensurabili. Un analfabeta disegna come un bambino di quattro anni, non vede le proporzioni, non sa riprodurre una prospettiva. Come si può spiegare, Perché leggi?
Mhm3 non capirà la polizza di un’assicurazione o i termini di un contratto di lavoro, e resterà nella fascia debole della popolazione, quella a bassa scolarizzazione facilmente raggirabile, con un trauma inguaribile, aver visto morire suo fratello, che sarà la prima cosa che racconterà quando gli chiederanno da dove sei venuto. E la morte albergherà in lui come un segmento del suo corredo genetico e quello che abbiamo in comune è proprio l’incapacità di trovare le parole per descrivere il dolore, l’ineffabile e “divina indifferenza” al di là del titolo di studio.
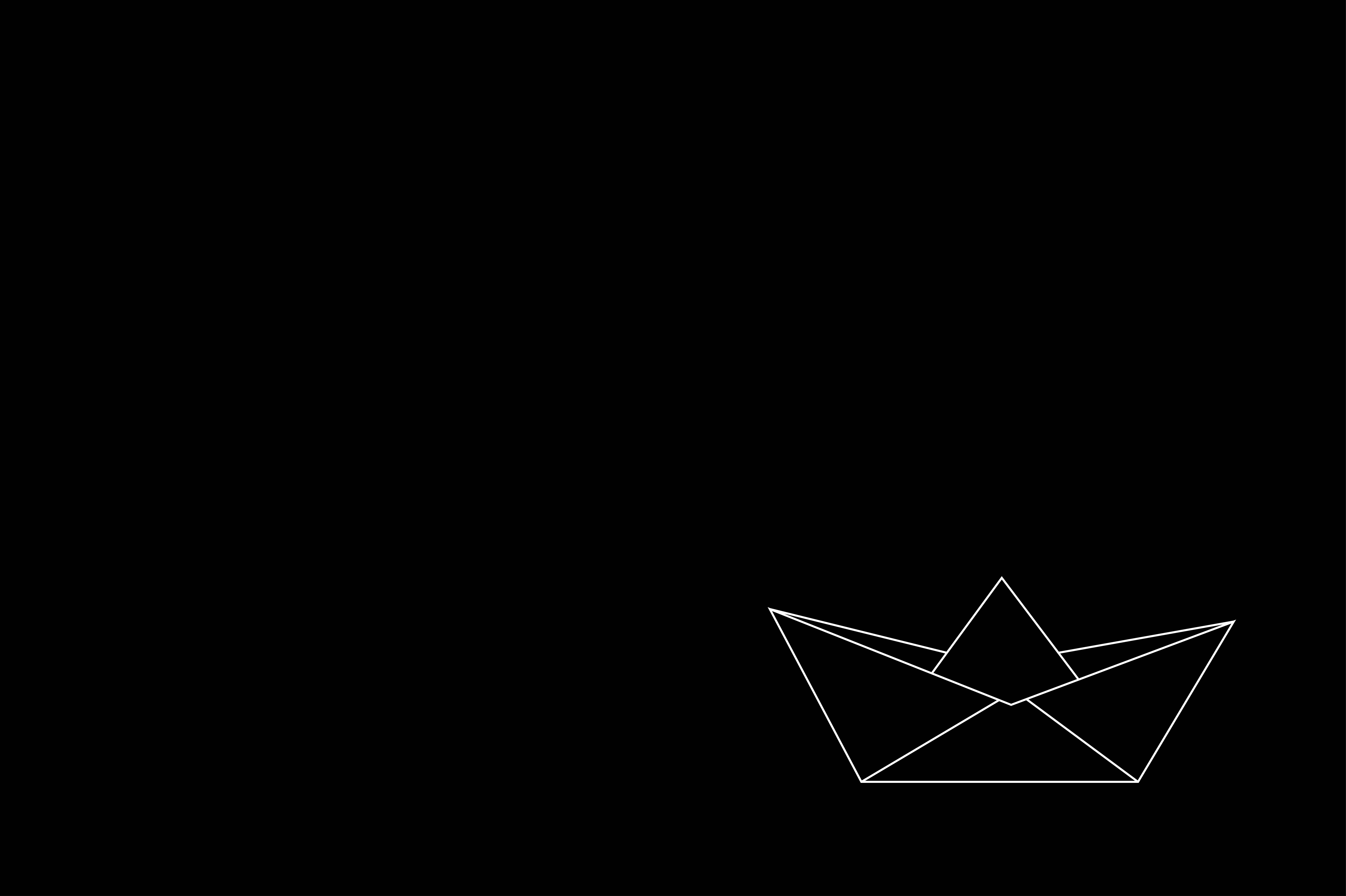
di Valentina Avoledo

